Quando si pensa alla Malattia di Parkinson (PD), la prima immagine che spesso emerge è quella del tremore a riposo, della rigidità o della bradicinesia (lentezza dei movimenti). Questi sono indubbiamente i sintomi motori distintivi di questa patologia neurodegenerativa progressiva, causati principalmente dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici nella substantia nigra mesencefalica, una struttura essenziale per il controllo e l’organizzazione delle attività motorie.
Ma accanto ai disturbi del movimento, esiste un altro aspetto, spesso trascurato ma clinicamente rilevante: il declino cognitivo nel Parkinson, che può manifestarsi sin dalle fasi iniziali e peggiorare nel tempo.
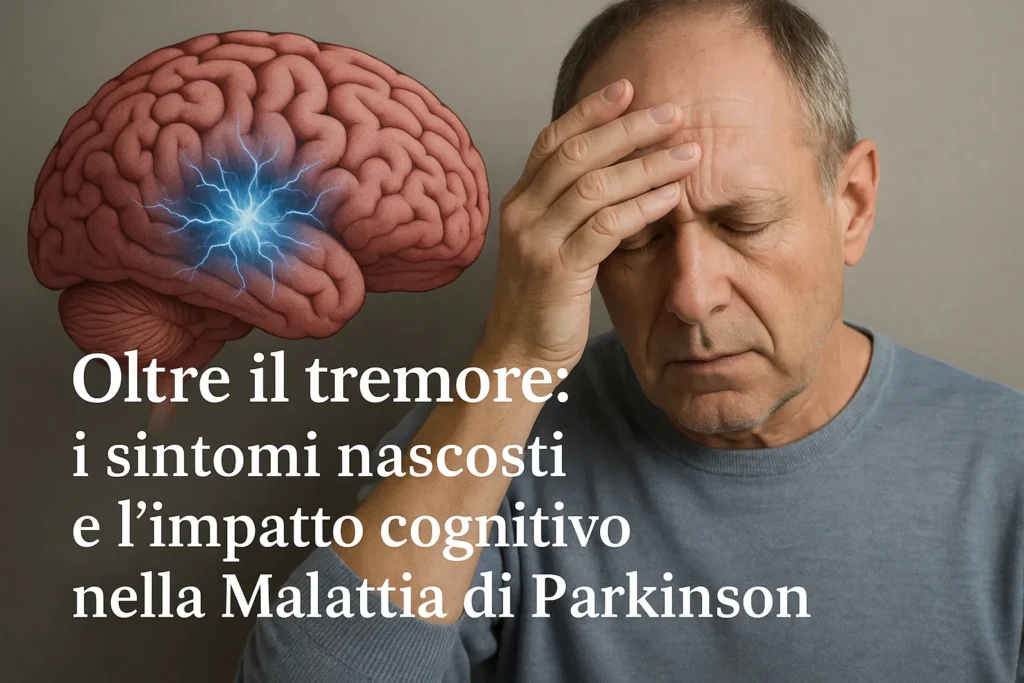
Ridurre la Malattia di Parkinson a una mera condizione motoria significa ignorare una componente significativa e spesso invalidante: i sintomi non motori, in particolare quelli cognitivi e neuropsichiatrici. Questi disturbi includono difficoltà di attenzione, memoria, linguaggio, funzioni esecutive e perfino allucinazioni visive nei casi più avanzati.
È interessante notare come la comprensione di questa malattia sia evoluta nel tempo. Agli inizi dell’Ottocento, James Parkinson stesso affermò che i “sensi e l’intelletto” rimanevano “illesi”. Solo sessant’anni più tardi, Jean-Martin Charcot iniziò a osservare che “la mente si annebbia e la memoria è persa”. Oggi sappiamo che Charcot aveva ragione: la PD è una condizione complessa, che coinvolge il cervello anche sul piano cognitivo.
La Malattia di Parkinson e il cervello che cambia: un Focus Cognitivo
È sempre più evidente che la Malattia di Parkinson presenta numerosi sintomi non motori, tra cui una significativa compromissione cognitiva. I deficit cognitivi possono manifestarsi già nelle fasi precoci della malattia, ma tendono ad aumentare con la progressione. Si stima che circa il 40% dei pazienti con PD mostri una compromissione in diversi domini cognitivi, percentuale che sale all’80% negli studi longitudinali, indicando come questi deficit diventino più frequenti con il passare del tempo.
Quali sono i domini cognitivi più frequentemente interessati?
- Attenzione e memoria di lavoro.
- Funzioni esecutive (capacità di pianificazione, problem solving, flessibilità cognitiva).
- Linguaggio.
- Abilità visuo-spaziali.
- Memoria episodica.
Inizialmente, i deficit cognitivi possono essere lievi, tanto da non interferire significativamente con le attività quotidiane. Questa fase viene definita Mild Cognitive Impairment nella Malattia di Parkinson (PD-MCI), una condizione in cui i pazienti con Malattia di Parkinson (PD) presentano un deterioramento cognitivo al di sopra di quanto atteso per l’età, ma che non compromette ancora significativamente la loro autonomia nelle attività quotidiane. La diagnosi di PD-MCI richiede la valutazione di specifici domini cognitivi e può essere un predittore importante dell’insorgenza successiva di demenza. Il profilo cognitivo del PD-MCI è eterogeneo, ma si distingue da quello dell’Alzheimer per deficit esecutivi e, a volte, visuo-spaziali più marcati, con disturbi di memoria relativamente meno gravi.

Quando il declino diventa demenza: il Complesso PD-D
Negli stadi tardivi della malattia, i deficit cognitivi e comportamentali possono evolvere fino a produrre il complesso demenza-malattia di Parkinson (PD-D). Questa complicanza tardiva ha un impatto significativo sulle attività quotidiane, riducendo l’autonomia del paziente e aumentando la morbilità e la mortalità.
Il quadro clinico del PD-D va oltre la classica sindrome disesecutiva, quell’insieme di deficit nelle funzioni cognitive di alto livello come la pianificazione e il problem-solving, che sono strettamente legati alla disfunzione dopaminergica nel sistema dei nuclei della base. A differenza delle fasi iniziali della PD, in cui i problemi di memoria riguardano soprattutto la rievocazione, nel PD-D si osservano anche deficit nella memoria di riconoscimento, ovvero la capacità di identificare un’informazione già incontrata in precedenza. A questi si aggiungono la compromissione delle abilità visuo-percettive, fluttuazioni cognitive e allucinazioni visive.
Queste ultime sono particolarmente frequenti nei casi di demenza avanzata, con una prevalenza che può raggiungere il 60-70% negli stadi più severi della PD-D, mentre nella popolazione generale con PD si attestano intorno al 20-40%. Sebbene possano essere indotte da farmaci, trovano il loro principale fattore di rischio nel decadimento cognitivo stesso.
È importante notare la stretta relazione tra PD-D e la Demenza a Corpi di Lewy (LBD). Le due condizioni presentano un’ampia sovrapposizione di caratteristiche cliniche, neuropsicologiche e neuropatologiche, inclusa la presenza diffusa di corpi di Lewy (aggregati proteici di alpha-sinucleina) all’esame autoptico. Questa analogia ha suggerito che PD-D e LBD possano rappresentare due diversi fenotipi dello stesso processo patogenetico.
La valutazione neuropsicologica: una bussola nel declino cognitivo
La complessità del quadro cognitivo nella PD sottolinea l’importanza di una valutazione neuropsicologica approfondita. Questa non si limita alla diagnosi di demenza, ma è fondamentale per monitorare l’evoluzione dei deficit e differenziare le caratteristiche della compromissione.
Le scale globali più adeguate per la valutazione delle abilità cognitive nella PD includono il Montreal Cognitive Assessment (MoCA), le Scales for Outcomes of Parkinson’s Disease-Cognition (SCOPA-Cog) e la Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS). È importante sottolineare che test come il Mini Mental State Examination (MMSE), pur utili in altre demenze come l’Alzheimer, non sono sufficientemente sensibili alla compromissione fronto-striatale tipica della PD-D.
Una valutazione di secondo livello, più approfondita, indaga specificamente l’efficienza cognitiva globale, le caratteristiche della compromissione fronto-striatale, le funzioni mediate dalle strutture corticali posteriori e le caratteristiche neuropsichiatriche. Particolare attenzione viene data alla memoria, cercando di distinguere tra un deficit di tipo “ippocampale/temporale mediale” (più simile all’Alzheimer, con difficoltà di codificazione e consolidamento) e un deficit di tipo “fronto-striatale” (tipico della PD, legato a problemi di attenzione e recupero strategico).
Un aspetto emergente e ancora troppo trascurato nella valutazione clinica della PD è la cognizione sociale. È noto che nella PD sia compromesso il riconoscimento delle emozioni (da volto o voce), specialmente quelle negative. Questo deficit può manifestarsi precocemente, anche prima di un evidente decadimento cognitivo.
Verso una comprensione integrata
La comprensione della Malattia di Parkinson è in continua evoluzione. Dalla visione iniziale di una malattia puramente motoria, siamo giunti a riconoscere un quadro clinico variegato, in cui i sintomi non motori, in particolare quelli cognitivi e neuropsichiatrici (come apatia, umore depresso/ansioso, allucinazioni e deliri ), giocano un ruolo centrale nell’impatto sulla qualità di vita del paziente e del caregiver.
La ricerca continua a svelare i complessi meccanismi fisiopatologici sottostanti il PD-D, che spesso includono non solo i corpi di Lewy, ma anche altre alterazioni cellulari e fattori genetici che aumentano il rischio.
Per i professionisti della salute e per i pazienti, è fondamentale un approccio multidisciplinare che integri neurologia, neuropsicologia e psicologia clinica. Solo attraverso una valutazione completa e una gestione integrata è possibile affrontare le molteplici sfide poste dalla Malattia di Parkinson, migliorando la diagnosi, il monitoraggio e, non in ultima analisi, la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Riferimenti Bibliografici
Aarsland, D., Pahlhagen, S., Ballard, C. G., Müller, V., & Ballard, C. (2012). Parkinson’s disease-dementia: diagnosis, clinical and pathological features and treatment. International Journal of Geriatric Psychiatry, 27(6), 566–576.
Breder R, Leite MAA, Pinto JA Jr, Cavalcante IP, Pessoa BL, Neves MAO. Low Sensitivity of the Mini-Mental State Examination for Cognitive Assessment of Brazilian Patients With Parkinson Disease. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2017 Nov;30(6):311-315.
Charcot, J.M. (1877). Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. Paris: Delahaye et Lecrosnier.
Fénelon, G., Mahieux, F., Huon, R., & Ziégler, M. (2000). Hallucinations in Parkinson’s disease: prevalence, phenomenology and risk factors. Brain, 123(4), 733-745.
Gibson LL, Abdelnour C, Chong J, Ballard C, Aarsland D. Clinical trials in dementia with Lewy bodies: the evolving concept of co-pathologies, patient selection and biomarkers. Curr Opin Neurol. 2023 Aug 1;36(4):264-275.
Kawamura, K., & Shimohama, S. (2021). Etiology and Treatment Approach for Visual Hallucinations in PD Dementia. In Parkinson’s Disease – Understanding Pathophysiology and Developing Therapeutic Strategies. IntechOpen.
Litvan, I., Goldman, J.G., Tröster, A.I., Schmand, B.A., Weintraub, D., Petersen, R.C., et al. (2012). Diagnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. Movement Disorders, 27(3), 349–356.
McKeith, I. G., et al. (2020). Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology, 95(17), 785-797.
Parkinson, J. (1817). An Essay on the Shaking Palsy. London: Sherwood, Neely, and Jones.
Zadikoff C, Fox SH, Tang-Wai DF, Thomsen T, de Bie RM, Wadia P, Miyasaki J, Duff-Canning S, Lang AE, Marras C. A comparison of the mini mental state exam to the Montreal cognitive assessment in identifying cognitive deficits in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2008 Jan 30;23(2):297-9.

